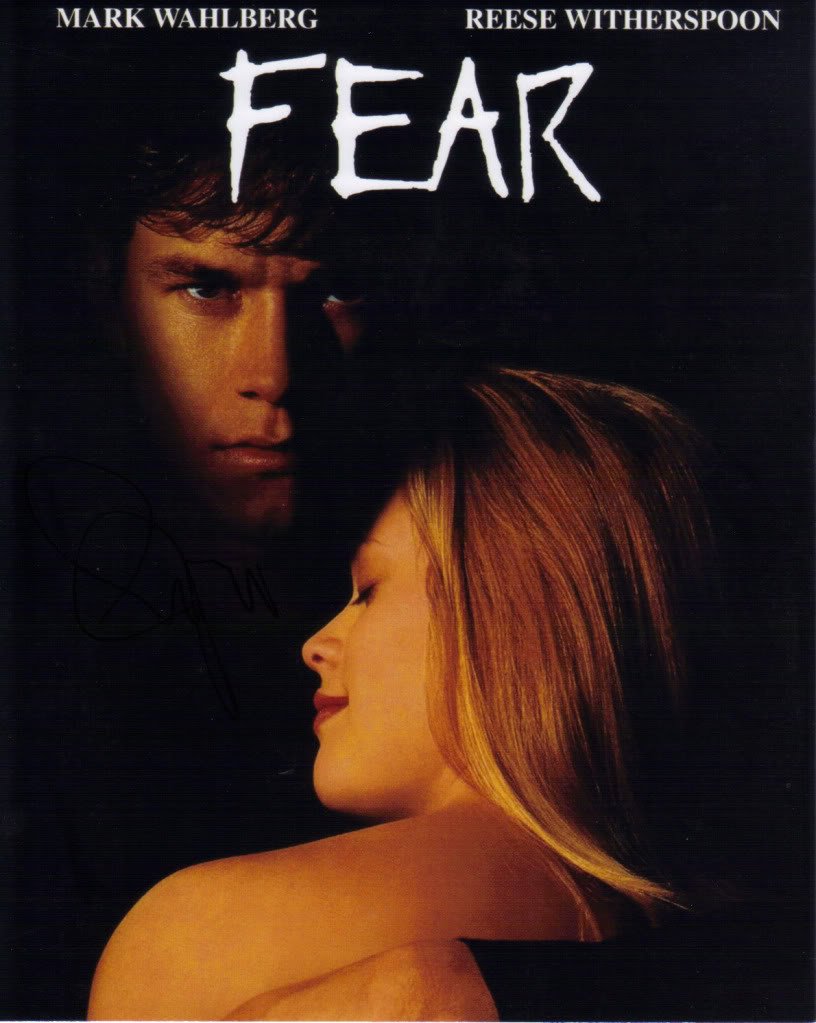Fu un caso letterario: un giovane giallista svedese che raggiunge un
successo planetario con una corposa trilogia di thriller molto
singolari, pubblicati in parte postumi, perché Stieg Lasson muore
all'improvviso nel 2004, poco dopo aver consegnato il manoscritto
all'editore svedese, quando prometteva ancora molto o forse aveva già
dato tutto. Tre opere corpose, con storie e personaggi che si
accavallano in un viluppo di rimandi che tarda a districarsi.
Ho amato
quei tre libri e ho giudicato con sospetto l’inevitabile tentativo di
tradurli in film. Poi mi sono fatto coraggio e mi sono visto “Uomini che
odiano le donne” (2009). Il giudizio é sostanzialmente positivo,
intanto ho visto fugato il pericolo di trovare la storia semplificata e
acchitata da film made in Usa, con epici coloratissimi panorami e attori
acqua e sapone di bellezza. No, i panorami sono quelli lividi e un po’
tristi di un paese di freddo e di neve e i volti dei personaggi non
hanno nulla o molto poco di “cinematografico” nel senso usuale. La
vicenda, con le necessarie semplificazioni nel passaggio da settecento
pagine a due ore di cinema, conserva quel tono di lenta, metodica ma
intrigante scoperta di una famiglia grande e corrotta, nel gioco di
personaggi abbietti. Credo che non vedrò il remake made in Usa del 2011,
con lo 007 Daniel Graig in missione speciale, anche se i più solerti
recensori gli danno una stelletta in più.
Ho completato la visione
del secondo e terzo film - tre film molto svedesi - tratti dalla
trilogia “Millennium” di Stieg Larsson: “La ragazza che giocava con il
fuoco” e “La regina dei castelli di carta”. Film molto svedesi non solo
perché realizzati e interpretati in Svezia da attori svedesi, ma perché
così intimamente si collegano al nuovo immaginario che cinema e
televisione hanno costruito negli ultimi anni.
Della Svezia e in
generale di quel Nord Europa scandinavo, stretto nella morsa del gelo e
popolato di belle ragazze bionde e disinibite che d’estate transumavano
nei nostri mari, conoscevano, in termini cinematografici, molto poco: le
opere allucinate e allucinanti di Carl Theodor Dreyer, il mito delle
grandi attrici planate negli Usa, da Greta Garbo a Ingrid Bergman, e poi
le numerose incursioni di Ingmar Bergman nei territori
dell’inquietudine spirituale. Da giovanissimo amavo anche i rari film
esportabili di Vilgot Sjoman, uno studioso di cinema e regista che poi
conobbi a Venezia, film disinibiti e trasgressivi, che raccontavano temi
sociali e personaggi tormentati in maniera provocatoria ed esplicita,
ma quei film dovevo andare a vedermeli a Parigi, in un cinemetto della
Rive Gauche. Poi c’era l’immagine, liberante e insieme triste che di
quel paese, lontano da noi molto più dei chilometri che ci separano,
avevano dato due italiani di cinema, Gian Luigi Polidoro e Albero Sordi:
il paese della libertà sessuale, talmente disinibito da farti
rimpiangere, a conti fatti, il nostro costume retrogrado e bacchettone.
E
adesso, da non molti anni, c’è un grande ritorno, specie in cinema e
tv, serie che vengono puntualmente copiate dagli USA, libri “gialli” che
vengono puntualmente tradotti diventando best-seller e i tre capolavori
– possiamo definirli tali ? - dello sfortunatissimo Stieg, compendio di
iniquità spionistiche, di speculazioni selvagge, di sfrenata violenza e
libertà sessuale, di scatenato giornalismo d’inchiesta, di amori
perversi con al centro il personaggio femminile più singolare della
nuova narrativa: Lisbeth, hacker in abiti da irriducibile metallara,
lesbica disinibita e complessatissima creatura che deve continuamente
fare i conti con un terribile passato. I tre film raccontano a modo loro
i tre romanzi ma ne conservano il succo e in gran parte gli umori,
l’ambiente un po’ scostante di quelle città, i volti, lontani
dall’immaginario svedese dei nostri anni giovanili, volti duri,
sofferti, non belli, di giovani ma non giovanissimi. Netflix ce li porta
in casa senza più bisogno di ricorrere al mio cinemetto parigino.