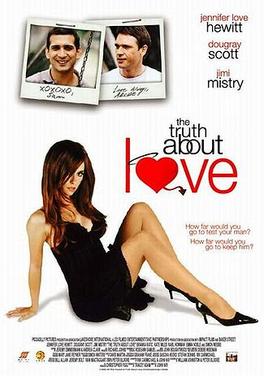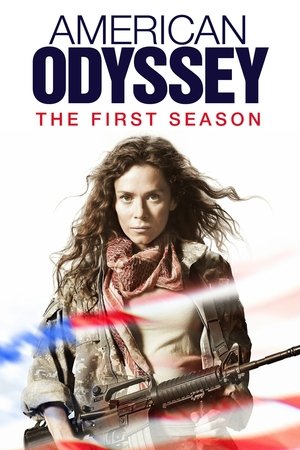Vendetta, tremenda vendetta!, invocava il povero Rigoletto brutalmente
offeso e ferito negli affetti da quel farfallone del Duca di Mantova.
Vendetta, ripete a se stessa la bionda fanciulla che, sulla tracce di
Rigoletto o più ancora del vendicativo Conte di Montecristo, si appresta
a far piazza pulita dei nemici che le hanno rovinato l’esistenza,
separandola bambina da suo padre e trasformando il genitore, a forza di
menzogne e di truffe, da fortunato finanziere in
condannato per crimini diversi quanto efferati. E la bionda fanciulla,
una volta cresciuta e trasformatasi in un’avvenente e navigata
capitalista – speriamo ci venga spiegato prima o poi come ha fatto - si
accinge a rovinare tutti quelli - e sono proprio tanti – che hanno fatto
del male a lei e all’amato e perduto genitore.
Se non fosse un
fanciulla moderatamente bellina, la protagonista di “Revenge” ci
apparirebbe un’erinni decisamente sadica, non certo degna della nostra
approvazione, che invece siamo ben disposti a concederle, visto che è
l’eroina della serie di cui stiamo vedendo le prime puntate, serie che
vanta come primo nome in cartellone quello della navigata Madeleine
Stowe, un po’ stagionata e quindi retrocessa al ruolo di avvenente
genitrice.
La serie si fa vedere con interesse, è piacevole, pullula di
personaggi giovani dalla storia sufficientemente prevedibile e, con
l’aiuto degli ormai consueti immancabili flashback, ci fa recuperare via
via i tristi trascorsi di papà, della bimba nonché degli amici-nemici
che la fanciulla si appresta ad abbattere uno dopo l’altro, come
altrettanti birilli. Ci chiediamo come lo schema abbia potuto resistere
per ben quattro stagioni ma andiamo avanti con piena fiducia.
SPOILER (QUARTA STAGIONE)
Con la 23° puntata della quarta stagione ho concluso personalmente la
visione di questa serie, trasmessa in Usa con successo dal 2011 al ‘15 e
vagamente ispirata alla seconda parte del dumasiano “Conte di
Montecristo”, quella appunto destinata alla vendetta del Conte su tutti i
suoi nemici. E’ il fine perseguito dalla nostra Amanda sotto falso
nome: inseguire e distruggere tutti quelli che hanno causato la rovina e
la morte del proprio padre. Almeno sino a
quando la serie – nella sua quarta stagione - prende il largo dalla sua
ispirazione, con il ritorno del padre che non è morto e la lotta fa le
due “signore”, la terribile e seducente Victoria, a cui Madeleine Stowe
presta il suo volto e la sua silouette, e Amanda, che per meglio
vendicarsi ha assunto il nome di Emily, di cui la giovane Emily VanCamp
offre una valida interpretazione.
Interpretazioni tutte, quella delle
due dame come degli altri numerosi personaggi portanti, sempre un po’
sopra le righe, quasi una versione di lusso di quel rituale “sopra le
righe” mediata dalle fiction popolari, a base di sguardi infidi o
sornioni che annunciano in anticipo il comportamento dei personaggi.
La
serie, nel suo insieme, è appassionante, anche se talora si sviluppa un
po’ troppo “in progress”, aggiungendo risvolti, vicende e personaggi
strada facendo, per prolungarne la vita forse oltre il necessario.
Ecco,
le fiction popolari dovrebbero prenderne esempio: eventi che si
accavallano, sviluppi drammatici che si succedono “stile Matrioska”,
distinzione sempre facilmente individuabile fra i “buoni” e “cattivi, ma
con rovesciamenti di campo e inevitabili cambiamenti di rotta,
interpreti efficaci, personaggi ben caratterizzati, buona scelta degli
ambienti e dei costumi, a cominciare dal principale “luogo deputato”,
cioè le due ville non lontane dalla costa sabbiosa e dal mare.